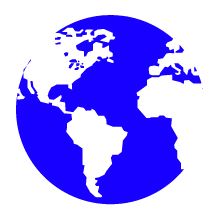ottobre 24, 2017
COLLOQUI INVESTIGATIVI E COLLOQUI A FINI PREVENTIVI
di Miriam Ferrara
A seguito degli attentati di Parigi del 7 gennaio 2015, l’Italia ha dato attuazione alla risoluzione O.N.U. del 24 settembre 2014 n.2178, con il d.l. n.7/2015, convertito con modificazione della legge 17 aprile 2015 n.47. Il “pacchetto antiterrorismo” ha in parte modificato gli strumenti di lotta al terrorismo, tra i quali vi rientrano anche i colloqui investigativi e quelli a fini preventivi.
I colloqui investigativi consentono di ottenere, in modo informale, informazioni rilevanti a fini investigativi da parte di soggetti detenuti o internati, in carcere o agli arresti domiciliari. L’istituto nacque con la legge n.356/1992, che inserì l’art. 18 bis all’interno dell’ordinamento penitenziario[1]. Il decreto Pisanu estese poi l’operatività della norma, parificando la minaccia mafiosa a quella terroristica, così da prevedere la “possibilità di acquisire informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico”[2]. Dall’esperienza acquisita nella lotta alla criminalità organizzata, il legislatore ha quindi previsto la possibilità di raccogliere informazioni da qualsiasi soggetto detenuto, anche per reati comuni, che potenzialmente potrebbe essere a conoscenza di notizie relative a condotte eversive. Lo stesso articolo stabilisce i soggetti legittimati a svolgere i colloqui: il personale della Direzione investigativa antimafia e antiterrorismo, dei servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri competenti in materia di terrorismo, gli ufficiali responsabili a livello centrale del Corpo della Guardia di Finanza, solo per quanto riguarda le ipotesi di finanziamento del terrorismo, ed infine il Procuratore Nazionale Antimafia, senza necessità di autorizzazione. Come già sottolineato, l’acquisizione avviene in modo completamente informale, in quanto è vietata qualsiasi documentazione o verbalizzazione, ed i dati così raccolti non possono essere mai utilizzati in ambito processuale. In caso di soggetti internati, condannati o imputati, i soggetti sopra indicati devono richiedere l’autorizzazione a procedere al Ministro della Giustizia, che generalmente delega tale adempimento al Capo di Gabinetto, presso il quale viene tenuto un apposito registro riservato relativo a tali autorizzazioni. Queste ultime contengono l’indicazione puntuale dei nominativi dei soggetti che procederanno al colloquio, e sono strettamente connesse all’istituto dove sono ristretti i soggetti che rilasceranno le informazioni utili: per tale motivo, qualora tra l’autorizzazione e il colloquio intervenisse un trasferimento presso altro istituito penitenziario, sarà allora necessaria una nuova autorizzazione.
Dopo lo svolgimento del colloquio, il Direttore dell’Istituto trasmette, attraverso un modulo predisposto, i nominativi dei soggetti che hanno svolto l’intervista sia all’autorità competente al rilascio dell’autorizzazione che, per prassi ormai consolidata, anche al Ministero della Giustizia. In casi di particolare urgenza, attestati con provvedimento del Ministro dell’Interno o, per sua delega, dal Capo della polizia, non è richiesta l’autorizzazione e del colloquio viene data immediata comunicazione al Ministero della Giustizia, che provvede all’annotazione nel registro. Se si tratta di soggetti sottoposti alle indagini, invece, l’autorizzazione deve essere richiesta al Pubblico Ministero che si occupa di queste; infine, nel caso di soggetti sottoposti agli arresti domiciliari per prassi non viene applicato l’art. 18 bis ord. pen., non essendo quindi richiesta alcuna autorizzazione bensì solo il consenso dell’interlocutore, salvo prescrizioni contrarie contenute nel provvedimento che ha disposto la misura.
Al comma 14 dell’art. 13 di cui al d.l. n.8/1991 è disposto che i collaboratori di giustizia non possono rendere dichiarazioni ai colloqui investigativi, almeno fino alla redazione del verbale illustrativo. Tale norma giustifica anche la previsione dell’art. 18 bis ord. pen., per la quale il Procuratore Nazionale Antimafia deve essere informato di ogni colloquio investigativo svolto. Prima di richiedere la prescritta autorizzazione, bisogna quindi domandare a quest’ultimo se il soggetto che dovrà partecipare al colloquio ha già iniziato o meno un percorso collaborativo, al fine di evitare la violazione della disposizione sopra citata.
Appare opportuno segnalare che dalla “Relazione annuale sulle attività svolte dal Procuratore nazionale e dalla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo nonché sulle dinamiche e strategie della criminalità organizzata di tipo mafioso”, presentata il 12 aprile 2017, risulta che nel periodo compreso tra il primo luglio 2015 de il 30 giugno 2016, sono stati effettuati un totale di 14 colloqui investigativi[3].
Istituto diverso ma affine a quello da ultimo menzionato sto è quello introdotto dall’art. 6 del d.l. n.7/2015, ai sensi del quale: “fino al 31 gennaio 2016, il Presidente del Consiglio dei Ministri, anche a mezzo del Direttore generale delle informazioni per la sicurezza, può richiedere che i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, ovvero personale dipendente espressamente delegato, siano autorizzati a colloqui personali con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni utili per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale”. Per far fronte all’attuale minaccia terroristica, il legislatore ha voluto evidentemente dotare i servizi di intelligence di un ulteriore strumento preventivo, da utilizzare però in un arco di tempo limitato e abbastanza ristretto.
In un’ottica di coordinamento sempre più necessario, è stato previsto l’organo politico debba richiedere l’autorizzazione all’organo giudiziario, più precisamente al Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, quando sussistono “specifici e concreti elementi informativi che rendono assolutamente indispensabile l’attività di prevenzione”. Nonostante la lacuna normativa, si ritiene competente il distretto nel quale è collocato l’istituto penitenziario dove si trova il soggetto che parteciperà al colloquio. Entro cinque giorni dallo svolgimento di questo, deve esserne successivamente data comunicazione scritta all’ufficio che ha rilasciato l’autorizzazione e al Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo; la stessa comunicazione deve essere poi resa, entro trenta giorni, al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Le informazioni raccolte nascono e muoiono all’interno dell’attività di intelligence, poiché anch’esse possono essere utilizzare a soli fini investigativi e non possono essere in alcun modo divulgate o menzionate. Non essendo personale di Polizia Giudiziaria, gli appartenenti ai servizi non hanno l’obbligo di trasmettere all’autorità giudiziaria l’eventuale notitia criminis che potrebbero acquisire nel corso dell’intervista. Devono però darne comunicazione al Direttore del servizio di appartenenza, il quale informerà il Presidente del Consiglio e la magistratura. Quest’ultimo può differire la comunicazione della notizia di reato solo “quando ciò risulti strettamente necessario al proseguimento delle finalità istituzionali del sistema di informazione per la sicurezza”, ovvero quando tale comunicazione può causare un pericolo per le finalità che l’intelligence persegue.
L’esperienza purtroppo insegna che l’ambiente carcerario spesso non raggiunge la finalità rieducativa che si prefigge, ma anzi diventa culla della formazione criminale. La stessa Direzione Nazionale Antimafia ha dichiarato che è necessario “un adeguato monitoraggio della numerosa popolazione carceraria di fede islamica, al fine di individuare possibili forme di proselitismo volte a realizzare, tra tale popolazione carceraria forme di radicalizzazione estrema della fede religiosa che possa portare alla formazione di cellule terroristiche, legate a Daesh”[4].
Un esempio emblematico è quello riguardante il soggetto marocchino espulso il 6 dicembre 2016: l’ex Ministro dell’Interno, Angelino Alfano, ha infatti dichiarato che lo straniero “aveva confidato ad un compagno di detenzione l’intenzione di realizzare, una volta libero, un attentato in Vaticano, utilizzando una macchina piena di esplosivo e un’arma di tipo kalashnikov, che gli sarebbero state procurate a Roma da un suo referente…si era radicalizzato durante la precedente detenzione presso il carcere Regina Coeli ed era stato indicato come responsabile dell’indottrinamento di un altro detenuto”[5].
A livello europeo, anche l’International Centre for the Study of Radicalisation and Political Violence sostiene che le prigioni europee siano il centro di gravità del movimento jihadista, dove spopola il proselitismo e vengono reclutati nuovi membri: secondo i loro dati infatti, circa il 57% dei foreign fighters hanno vissuto un periodo di detenzione prima della loro mobilitazione[6].
I futuri combattenti stranieri entrano in giovane età all’interno del sistema penitenziario per qualsiasi tipo di reato, dalla rapina[7] all’omicidio[8], e sono visti come una facile preda, fortemente vulnerabile, a causa della rabbia e dell’avversione verso le Autorità Statali, dello sradicamento dalla propria famiglia e dal proprio ambiente sociale, e dell’ostilità che trovano all’interno delle prigioni, dove i detenuti si dividono per religione, etnia e ideologia. Inoltre, tali individui risultano particolarmente utili agli scopi dell’ISIS poiché, essendo inseriti ed avendo legami con il circuito criminale del Paese di appartenenza, sono in grado di procurare, una volta radicalizzati, documenti di identità falsi, armi, soldi e case sicure per i nuovi “fratelli di fede”. Risulta quindi imprescindibile un controllo pregnante di ciò che avviene all’interno di questi luoghi di coltura; a parere di chi scrive, tale monitoraggio ben può essere attuato attraverso i colloqui investigativi e quelli a fini preventivi, che costituiscono uno strumento fondamentale in un momento come quello attuale, in cui è estremamente necessario raccogliere il maggior numero di informazioni possibili al fine di prevenire attacchi terroristici.
[1] Legge 26 luglio 1975, n. 354
[2] Art. 1 d.l. 144/2005
[3] Direzione Nazionale Antimafia, Relazione Annuale 2017, pag. 1
[4] Direzione Nazionale Antimafia, Relazione Annuale 2016, pag. 441
[5] Sito Istituzionale del Ministero dell’Interno, comunicato stampa 06/12/2016
[6] ICSR, Criminal Pasts, Terrorist Features: European Jihadists and the New Crime-Terror Nexus, pag. 29
[7] Come nel caso di Harry Sarfo, cittadino tedesco, poi partito per la Siria, che era stato condannato nel 2010 per una rapina in un supermercato.
[8] Come nel caso di Mehdi Nemmouche, cittadino francese che nel maggio del 2014 aveva ucciso quattro persone nel Museo Ebraico di Bruxelles, partito per la Siria dopo 3 settimane dal suo rilascio.
per scaricare il pdf: Colloqui investigativi